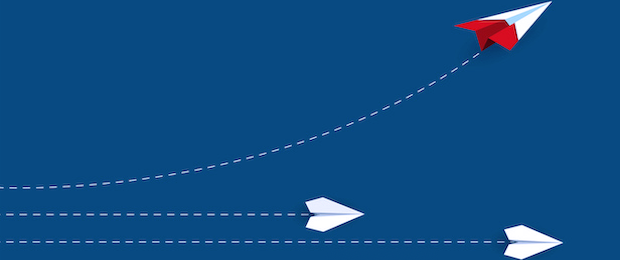Vecchiaia ed età pensionabile: quando andare in pensione nel 2024
Come andare in pensione (di vecchiaia) nel 2024? Anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio, facciamo chiarezza su età e requisiti contributivi richiesti a normativa vigente
Tendenzialmente, quando si parla in modo generico di pensione si fa riferimento alla cosiddetta pensione di vecchiaia, trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un’età anagrafica fissata per legge, in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni.
La pensione di vecchiaia: i requisiti (età + contributi) al 2024
Peculiarità della pensione di vecchiaia è quindi un requisito contributivo non eccessivamente severo – 20 anni, per l’appunto – a fronte di un requisito anagrafico ben più stringente: la cosiddetta età pensionabile per il 2024 è fissata a 67 anni (come già per il 2023, così come previsto da apposto decreto MEF del 27 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2021) per tutte le categorie di lavoratori, vale a dire uomini e donne, dipendenti e autonomi.
Come già visto, infatti, affinché il soddisfacimento del fabbisogno previdenziale possa essere mantenuto nel tempo, il sistema prevede alcuni elementi di stabilizzazione, introdotti anche per consentirgli di reggere alle trasformazioni demografiche in atto e al progressivo invecchiamento della popolazione: a tal fine, l’età pensionabile è quindi soggetta a degli adeguamenti periodici, in funzione della cosiddetta “speranza di vita”. Se la speranza di vita aumenta, aumenta cioè anche la soglia anagrafica da raggiungere per poter accedere alla pensione di vecchiaia. In particolare, a partire dal 2109 l’adeguamento avviene con frequenza biennale (in precedenza era invece triennale): questo vuol dire che il primo adeguamento dei requisiti con la nuova modalità sarebbe stato previsto per il biennio 2021-2022. Con il decreto del 5 novembre 2019, il MEF ha tuttavia stabilito, sulla base delle rilevazioni Istat sulla speranza di vita media, che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sarebbe rimasto fermo a 67 anni anche per il biennio 2021-2022. Con il successivo decreto datato 27 ottobre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inoltre confermato che, anche per 2023 e 2024, non è previsto alcun incremento dell’età pensionabile, ancora stabile quindi a 67 anni. E così dovrebbe essere anche per il biennio 2025-2026, per il quale si fa invece riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 18 luglio 2023.
Per quanto riguarda i contributi considerati, vale invece la pena di precisare che, ai fini del raggiungimento dei 20 anni, vale la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato: si considerano cioè egualmente “validi” contributi da lavoro, da riscatto, figurativi e versamenti volontari.
Casi particolari ed eccezioni: quando scatta la soglia dei 71 anni?
Il doppio requisito 67 anni d’età e 20 anni di contribuzione è valido in linea di massima, ma sono ovviamente previste alcune eccezioni, tanto che si può dire che, nel complesso, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia varia anche per l'anno in corso dai 66 ai 71 anni. In particolare:
- per i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia – spesso definita anche “pensione di vecchiaia contributiva” - a 71 anni (requisito a propria volta soggetto ad adeguamento demografico) a fronte del versamento di 5 anni di contributi, nei quali non sono però compresi in questo caso di contributi figurativi;
- per quanti avevano maturato al 31 dicembre 1992 almeno 15 anni di anzianità contributiva, possono bastare appunto anche solo 15 anni di contribuzione, a condizione che venga comunque soddisfatto il requisito anagrafico. A questo proposito occorre infatti precisare che la cosiddetta riforma Monti-Fornero ha di fatto “parificato” il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia tra i cosiddetti “contributivi puri” e quanti invece al gennaio 1996 avevano già una posizione assicurativa avviata, ma per quanto riguarda invece quello contributivo la circolare INPS 16/2013 dispone invece delle possibili deroghe;
- per i lavoratori che svolgono le “mansioni gravose” individuate come tali per legge, viene congelato anche per l’anno in corso l’adeguamento alla speranza di vita: questi lavoratori potranno cioè anche quest’anno accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età (a condizione però di essere in possesso di almeno 30 anni di contributi e di aver maturato una pensione di importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale);
- per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione, vale a dire “totalizzando” i contributi versati nel corso della propria vita lavorativa i contributi versati a più gestioni (Casse di Previdenza dei liberi professionisti comprese), il requisito anagrafico “scende” a 66 anni di età. Va però ricordato, che tra il diritto alla pensione e l’erogazione del primo assegno intercorre comunque una finestra di ben 18 mesi.
Merita poi particolare attenzione il caso dei cosiddetti “contributivi puri”, vale a dire quei lavoratori il cui primo versamento contributivo sia successivo alla riforma Dini e quindi decorra dall’1 gennaio 1996: per loro, il doppio requisito anagrafico e contributivo non sarebbe in realtà sufficiente secondo quanto disposto dalla riforma Monti-Fornero, che ne prevedeva infatti un terzo, riguardante l’importo dell’assegno maturato, di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (503,27 euro x 1,5 = 754,095 euro per l’anno 2023). Laddove non soddisfatto, la normativa vigente sino al 31 dicembre 2023 sanciva quindi che non fosse possibile ottenere la pensione, dovendo attendere – per prescindere dall’importo maturato - il raggiungimento dei 71 anni di età (“pensione di vecchiaia contributiva”).
La Legge di Bilancio per il 2024 (legge 212/2023, articolo 125) è tuttavia intervenuta su questo limite: nel 2024 è quindi possibile ottenere l’accesso al trattamento pensionistico, al netto dell’importo maturato, a 67 anni di età e con versamenti contributivi per almeno 20 anni, anche nel caso si rientri completamente all’interno del regime di calcolo contributivo della pensione.
Attenzione! In generale, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età pensionabile oppure, nel caso dei “contributivi puri” che (con riferimento alle pensioni maturate fino al 2023) non soddisfino al raggiungimento della soglia anagrafica anche il requisito relativo all’importo dell’assegno, dal mese successivo al suo soddisfacimento.
Chi raggiunge i requisiti è obbligato ad andare in pensione?
Il raggiungimento dei requisiti necessari a ottenere la pensione non implica di per sé che il lavoratore debba necessariamente pensionarsi. Con particolare riferimento alla pensione di vecchiaia, si può cioè dire che non si è obbligati ad andare in pensione al raggiungimento dei 67 anni di età: al contrario, la normativa vigente concede di proseguire anche oltre la propria carriera professionale (eventualità quest'ultima ovviamente da non confondere con la possibilità di riprendere a lavorare dopo la pensione cumulando l'assegno pensionistico con i redditi da lavoro, entro i limiti fissati dalla legge) fino al raggiungimento di un requisito anagrafico in corrispondenza del quale scatta invece il cosiddetto pensionamento forzato. In linea di massima, per i lavoratori del settore privato, tale soglia è pari ai 71 anni. Resta inteso l’accordo del datore di lavoro che, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, può comunque imporre al proprio dipendente il licenziamento per sopraggiunti limiti di età.
Diverse invece le regole nel settore pubblico, dove per lungo tempo si generalmente preferito favorire il pensionamento, seppur con qualche eccezione: in questo caso, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia scatta quindi pressoché in automatico la cessazione del servizio. Oltre tale data, il rapporto non può protrarsi se non, in via eccezionale, nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo richiesto (20 anni di contributi versati). Va d’altra parte precisato che spesso per le pubbliche amministrazioni scatta ancor prima il cosiddetto pensionamento d’ufficio, inteso appunto come l’obbligo o la facoltà a seconda delle amministrazioni di mandare in pensione il personale in servizio al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e/o contributivi. Al momento, l’obbligo scatta generalmente a 65 anni laddove, a tale età, il personale abbia maturato un qualsiasi diritto alla pensione (Quota 100 et similia comunque escluse); diversamente, il rapporto di lavoro prosegue fino al soddisfacimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia.
Attenzione! La revisione delle aliquote contributive prevista dalle Legge di Bilancio per il 2024 per le contribuzioni maturate ante 1996 agli assicurati - in possesso di meno di 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1995 presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro e ora dall’INPS dopo l’incorporazione dell’INPDAP per il personale del pubblico impiego (medici, personale sanitario, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari) non si applica in nessun caso alle pensioni di vecchiaia e a chi sia stato messo a riposo per sopraggiunti limiti di età.